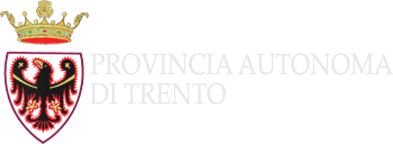Orazio Benevoli: il barocco colossale
Trento Musicantica 2009
soprani Dania Tosi, Sara Ricci, Erika Bonadiman,
Antonella Malacarne, Giulia Miscioscia, Letizia Grassi,
Monica Schmidt, Mariarosa Pontalti, Paola Lunelli,
Michela Pizzolato, Ivonne Dandrea, Aurora Faggioli
CORALE CITTÀ DI TRENTO
Direttore Roberto Gianotti
CANTORIA SINE NOMINE
Direttore Carlo Andriollo
CORO GIOVANILE I MINIPOLIFONICI
Direttore Stefano Chicco
CORO DEL LICEO MUSICALE DI TRENTO
Direttore Salvatore La Rosa
CORO DEL CONSERVATORIO F.A. BONPORTI DI TRENTO
Direttore Cecilia Vettorazzi
CORO DEL CONSERVATORIO F.A. BONPORTI DI RIVA DEL GARDA
Direttore Paolo De Zen
CORONA ARTIS
organo Stefano Rattini
clavicembalo Chiara Minali
fagotto Alberto Santi
violoncello Lorenzo Corbolini
violone Giuliano Eccher
Direttore e concertatore Roberto Gianotti
PROGRAMMA
Haec est Virgo sapiens
a quattro contralti
Si quis mihi ministraverit
a tre canti
Dirupisti Domine
a quattro soprani
Missa Angelus Domini
a dodici voci
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus-Benedictus / Agnus Dei
Regna terræ
a dodici soprani
Dixit Dominus
a ventiquattro voci
Il protagonista del concerto è il principale rappresentante del cosiddetto 'barocco colossale': il romano Orazio Benevoli (1605-1672), uno dei maggiori compositori di musica sacra di tutti i tempi. La riscoperta di questo straordinario autore si deve al sacerdote e musicologo Laurence Feininger (Berlino, 1909 - Campo di Trens, 1976) il cui lascito, raccolto in quarant'anni d'intenso studio e di solitaria ricerca, è ora conservato presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, unitamente all'immenso archivio fotografico e ai centoquarantadue volumi di trascrizioni pubblicate.
La scoperta entusiastica e lo studio della policoralità romana da parte di Feininger (che volle anche fondare nel 1949 e dirigere per vent'anni a Trento un grande coro che eseguisse le partiture da lui ritrovate: il Coro del Concilio) non fu ripresa da altri con l'impegno che meritava: le esecuzioni e le incisioni discografiche di opere di Benevoli sono ancora rarissime.
Il Festival internazionale Trento Musicantica da anni promuove la conoscenza e l'esecuzione delle opere del grande compositore romano, anche attraverso il coinvolgimento delle migliori compagini corali del territorio.
Di Benevoli sono proposti questa sera quattro mottetti da tre a dodici voci con basso continuo, l'intera Missa Angelus Domini a dodici voci, oltre al monumentale Salmo Dixit Dominus a ventiquattro voci.
La musica grandiosa a molte voci non è che un aspetto della produzione artistica di Orazio Benevoli. Non meno caratteristica, anche se meno cospicua, è la sua produzione di musica liturgica nel senso più stretto, cioè per l'uso in determinate occasioni liturgiche: antifone, responsori ed altre parti dell'Ufficio per le feste del tempo e dei santi.
Come nei brani concertati delle composizioni grandiose, così anche in queste composizioni più modeste, sia di estensione, sia di impiego di mezzi, egli ha una preferenza per voci pari o, comunque, per combinazioni di voci fuori delle quattro normali soprano - contralto - tenore - basso.
L'antifona Hæc est virgo sapiens, quam Dominus vigilantem invenit è la seconda dei Vespri delle Vergini.
Scrive Feininger: la forma dell'antifona 'Si quis mihi' per il Commune unius Martyris è la medesima che più tardi, sotto la disciplina più rigida di Bach, diventa Invenzione. Chiaramente si distinguono due motivi principali che per ben tre quarti dominano da soli tutto il pezzo: il primo Si quis mihi ministraverit, il secondo honorificabit eum, scala prima ascendente poi, a conclusione, discendente. Un terzo motivo, sulle parole qui est in celis, serve da divisoria tra le singole parti nello sviluppo. Nell'Invenzione e Fuga Bachiane ne deriva l'interludio.
Esso si trova già nella prima esposizione dell'intero materiale tematico all'inizio (nel Canto primo), poi ricompare brevemente elaborato in due voci alla fine della prima dase di sviluppo e poi in tutte le voci dopo la chiusura definitiva dello sviluppo tematico. Le parole conclusive dicit Dominus si appoggiano di nuovo al primo soggetto, senza perdersi in lungaggini o pedanterie.
L'antifona 'Dirupisti' appartiene ad una serie numerosa di simili antifone, tutte scritte per voci pari per i secondi Vespri degli Apostoli e conservate nell'archivio della Basilica Lateranense di Roma.
Sul mottetto 'Regna terrae' scrive Feininger nella prefazione all'edizione:
Il Mottetto Regna terræ per la festa dell'Ascensione è uno degli esempi rari del Benevoli l'unico, mentre dell'Abbatini se ne conoscono due; di altri ancora si sa soltanto che sono esistiti della spinta all'estremo delle possibilità sonore di un timbro unico, in questo caso di soprani, negli altri due casi di tenori e bassi.
La divisione in sei cori sembra indicare, che nell'occasione per cui fu composto sia stata eseguita anche un'altra musica a sei cori pieni, e che ogni coro abbia avuto almeno due cantori per ogni voce. Il raggruppamento invece delle voci a quattro e quattro indica chiaramente che, a sei, i cori furono collocati due a due, nella maniera seguente:
Questa supposizione viene corroborata anche dall'unico pezzo a sei cori pieni del Benevoli che ci è conservato, il Salmo Dixit Dominus 2. toni scritto nel 1658 per la canonizzazione di S. Tommaso da Villanova. Il primo coro sta di fronte al sesto, il direttore probabilmente stava col primo coro. Difatti, non sappiamo nulla di preciso sulla maniera in cui furono eseguite queste musiche a molti cori. Comunque, non sembra probabile che il maestro abbia diretto dall'istrumento, come divenne l'usanza per le musiche in un complesso unico, ma che non abbia fatto altro che battere il tempo e dare gli attacchi da un posto e in maniera visibile da tutti direttamente, o forse anche per mezzo di specchi.
Il fattore dello spazio, e del distacco spaziale tra i cori, è essenziale per questo genere di musica: l'ascoltatore deve trovarsi circondato dal suono e dall'armonia, e percepire l'integrazione spaziale proveniente dalle diverse parti dell'ambiente. La moltitudine di voci non è quindi fine a sé, ma bensì mezzo per esprimere lo spazio nella musica, come lo esprime la prospettiva nella pittura: si ricordi il soffitto di S. Ignazio a Roma!
Solo ora critici e musicologi cominciano ad accorgersi della grandezza di Benevoli, le cui partiture furono scoperte, studiate e poi pubblicate integralmente da Laurence Feininger a partire dal 1948. In una lettera del settembre 1948 Feininger scriveva: Riesco a vedere ora, in questa musica barocca colossale, uno sviluppo profondamente logico e, da un punto di vista liturgico, così valido da raggiungere con ogni probabilità l'acme assoluto di ciò che può essere raggiunto... così, il gigantesco allargamento del cantus firmus all'unisono in tutti i cori, alla fine delle fughe del Gloria e del Credo, è chiaramente un'eredità del Rinascimento e addirittura della pratica medioevale del cantus firmus; ma l'elemento veramente nuovo è che ora se ne è perfettamente consci e con un'intenzione davvero moderna ed esplicita esso è impiegato come mezzo per un'espressione musicale in grado di rapire concretamente una moltitudine di persone devote, portandole ad uno stato molto vicino all'estasi.
La sempre affascinante scrittura di Benevoli, che sa alternare sapientemente momenti di grande cantabilità a momenti corali di intensa potenza espressiva, con un controllo estremamente vigile del contrappunto e un'attenzione non comune al testo sacro, rendono le sue opere sommamente godibili e le pongono fra le maggiori produzioni di musica sacra di tutti i tempi.
Marco Gozzi
organizzazione: Centro Servizi Culturali S. Chiara e Il Virtuoso Ritrovo - collaborazione di Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento